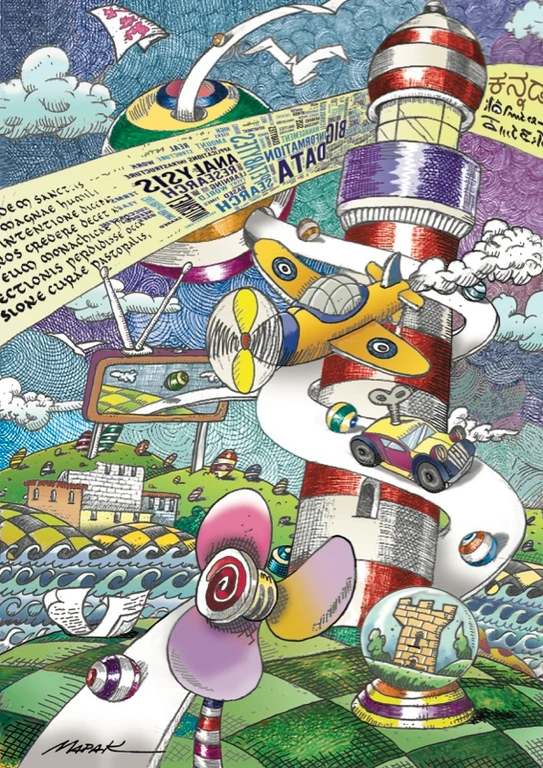di Riccardo Bocci – Tratto da Nautilus rivista – Gennaio 2025
Le sementi hanno un immaginario sociale che le fa uscire dall’essere solo un mezzo di produzione in agricoltura. Infatti, i nomi delle varietà, le loro caratteristiche sono legate alla nostra storia, un tempo definivano i nostri orizzonti simbolici, gusti e sapori sono legati alla nostra tradizione e alla cucina. Ma c’è di più. Chi controlla i semi, controlla il sistema alimentare e quello che mettiamo nei nostri piatti. Ecco perché parlare di sementi non è facile e tocca delle corde emotive che normalmente non sono considerate dai tecnicismi con cui di solito si tratta la materia agricola. Senza capire tutti questi fili che legano le sementi alle società non si possono realizzare delle serie politiche sementiere, in grado di rispondere a tutte le aspettative dei molti e variegati attori coinvolti. Soprattutto, però, non si riesce a spiegare l’interesse che questo mezzo tecnico ha per cittadini che, ormai, sono molto lontani dalla pratica del fare agricoltura. Nel mondo urbano, che idealizza l’agricoltura vissuta come un’arcadia di cartapesta, i semi hanno un ruolo centrale, diventando antichi, naturali, autoctoni o ancestrali, nel tentativo impossibile di richiamare un mondo contadino scomparso.
Difficile se non impossibile coniugare questa nuova cosmologia nostalgica con il sistema di leggi e regole che nel frattempo sono state sviluppate sulle sementi. Proviamo a fare una veloce sintesi. A livello europeo le sementi sono regolate da 12 differenti direttive che si occupano di definire quali sementi possono essere messe in commercio. Si tratta dei famosi criteri di Distinzione, Uniformità e Stabilità (DUS), che, in essere dagli anni ’60 del secolo scorso, hanno contribuito a far scomparire la diversità dalle nostre campagne. A livello internazionale abbiamo la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) e il relativo Protocollo di Nagoya che si occupano di definire le regole all’accesso alle risorse genetiche a fini di ricerca; il Trattato Internazionale sulle Risorse Genetiche Vegetali per l’Agricoltura e l’Alimentazione che definisce l’accesso alle sementi; e in ultimo la convenzione UPOV che riguarda la proprietà intellettuale sulle nuove varietà. In Italia, poi, il quadro si complica con la legge nazionale 194 del 2015 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” e le molte leggi regionali sulla agrobiodiversità. Come si capisce un mare di carta e burocrazia nel quale non è facile navigare.
Uno dei temi più di battuti è quello della proprietà: a chi appartengono i semi? Sono degli agricoltori che li coltivano? Delle ditte sementiere o dei ricercatori che creano le nuove varietà? Sono un bene comune, patrimonio dell’umanità? Oppure hanno un proprietario, il presunto inventore, così come capita a un qualsiasi oggetto?
Non è facile rispondere. Il sistema legale descritto prima ci racconta che le nuove varietà, se distinte, uniformi e stabile, sono di proprietà di chi le crea, addirittura si possono brevettare, con il classico brevetto industriale. All’opposto le varietà antiche, o meglio locali se vogliamo uscire dalla narrazione da Mulino bianco, sono in pubblico dominio perché non uniformi o troppo vecchie per essere protette. Ma cosa vuol dire pubblico dominio? Significa che giuridicamente non hanno un proprietario, ma un possessore: l’agricoltore che le coltiva. Quando, però, queste varietà locali vengono conservate nelle banche delle sementi pubbliche (di università e centri di ricerca) diventano di proprietà dello Stato stesso, in quanto la CBD ha dato la sovranità nazionale alla biodiversità che si trova nel suo territorio. Tecnicamente, quindi, non sono più patrimonio comune dell’umanità dall’entrata in vigore della CBD nel 1994 e non possono essere considerate un bene comune.
Tutto chiaro e definito? In realtà no. Se usciamo dal mondo delle varietà migliorate, protette e rispondenti ai criteri DUS, e entriamo in quello delle varietà diversificate (popolazioni, varietà locali, materiali eterogenei biologici, solo per nominare alcuni esempi), in pubblico dominio, ci si apre uno spazio incredibile in cui lavorare per ricostruire quei legami sociali che si sono persi intorno alle sementi, negoziando un nuovo sistema di regole che ogni comunità può definire intorno ad uso, scambio e circolazione delle proprie sementi. Non proprio un bene comune ad accesso libero, ma qualcosa di diverso dove l’azione collettiva trova la sua centralità nel processo di innovazione sociale e le sementi diventano volano per la costruzione di sistemi alimentari alternativi, non solo da un punto di vista agronomico.
Negli interstizi dimenticati dalla modernizzazione le sementi sono di chi se ne prende cura e le usa come strumento di costruzione di un’altra società.